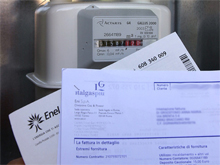L’immunità parlamentare in Italia rappresenta un elemento fondante del diritto costituzionale, volto a tutelare l’autonomia e la libertà d’azione dei membri del Parlamento (deputati e senatori) nell’esercizio delle loro funzioni.
Non si tratta di un privilegio personale, bensì di una garanzia istituzionale, essenziale per il corretto funzionamento delle Camere e per la salvaguardia della separazione dei poteri e le sue origini sono riconducibili alla storia delle democrazie moderne, dove si è riconosciuta la necessità di proteggere i rappresentanti del popolo da possibili abusi del potere esecutivo o giudiziario.
In Italia, le disposizioni sull’immunità sono contenute principalmente nell’articolo 68 della Costituzione, il quale è stato oggetto di diverse e impattanti modifiche nel corso del tempo, evidenziando un cambiamento nella comprensione e nell’applicazione del delicato equilibrio tra garanzia parlamentare e principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
In questo articolo parliamo di:
L’insindacabilità dei parlamentari
L’immunità parlamentare in Italia si articola in due forme distinte, ciascuna con una sua specifica finalità e ambito di applicazione: l’insindacabilità e l’inviolabilità.
L’insindacabilità (o immunità per le opinioni espresse e i voti dati) è disciplinata dal primo comma dell’articolo 68 della Costituzione: “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.” Questa forma ha carattere sostanziale e permanente, estinguendosi solo con la cessazione del mandato parlamentare. Significa che un parlamentare non può essere perseguito civilmente, penalmente o disciplinarmente per quanto detto o votato in Aula, durante i lavori delle commissioni, o in qualsiasi altra attività che sia direttamente riconducibile all’esercizio tipico delle funzioni parlamentari.
La ratio è quella di garantire ai parlamentari la piena libertà di dibattito, di critica e di espressione, senza il timore di ritorsioni giudiziarie che potrebbero limitare il loro operato e, di conseguenza, la stessa rappresentatività del Parlamento. Al riguardo, la Corte Costituzionale ha più volte chiarito che l’insindacabilità opera solo quando le opinioni espresse o i voti dati siano “funzionali” all’attività parlamentare.
L’inviolabilità dei parlamentari
L’inviolabilità (o immunità processuale), regolata dal secondo e terzo comma dell’articolo 68, è invece di natura processuale e ha carattere temporaneo, cessando con la conclusione del mandato parlamentare. Prima della riforma costituzionale del 1993, tale principio era molto più esteso e prevedeva che nessun membro del Parlamento potesse essere sottoposto a procedimento penale senza l’autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza. Con la revisione dell’articolo 68, il campo di applicazione è stato drasticamente ridotto e, attualmente, l’autorizzazione della Camera è richiesta solo per l’arresto (salvo in caso di sentenza irrevocabile di condanna o di flagranza di reato per il quale è obbligatorio l’arresto), per l’assoggettamento a misure cautelari personali o reali, e per perquisizioni personali o domiciliari e non è più necessaria l’autorizzazione per l’avvio di un procedimento penale o per l’effettuazione di indagini.
La modifica è stata introdotta per bilanciare la tutela dell’autonomia parlamentare con l’esigenza di assicurare l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e di evitare che l’immunità si trasformasse in un vero e proprio privilegio.
La riforma del 1993
La riforma dell’articolo 68 della Costituzione del 1993 ha rappresentato un momento fondamentale nella storia dell’immunità parlamentare italiana. Prima di questa riforma, la cosiddetta “autorizzazione a procedere” era richiesta per l’avvio di qualsiasi azione penale nei confronti di un parlamentare, con un sistema che aveva generato non poche critiche, in quanto si riteneva che potesse ostacolare il lavoro della magistratura e, in alcuni casi, fungere da scudo per condotte illecite.
Il dibattito pubblico, in particolare durante il periodo di Tangentopoli, evidenziò la percezione di un’eccessiva protezione dei parlamentari, in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini.
La revisione costituzionale ha concretamente ridotto la portata dell’immunità processuale e oggi, come detto in precedenza, l’autorizzazione della Camera è circoscritta esclusivamente alle misure che comportano una limitazione della libertà personale o domiciliare (arresto, altre misure restrittive della libertà personale, perquisizioni personali o domiciliari, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) e per i provvedimenti di sequestro di corrispondenza.
L’avvio di un’indagine preliminare o di un procedimento penale non richiede più alcuna autorizzazione, rafforzando il principio che i parlamentari, per quanto riguarda la giustizia penale, sono soggetti alle stesse regole degli altri cittadini, pur mantenendo quelle garanzie essenziali per l’esercizio delle loro funzioni rappresentative.
Ruolo delle Camere e della Corte Costituzionale
Quando si rende necessaria un’autorizzazione, spetta alla Camera di appartenenza (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) deliberare sulla richiesta avanzata dall’autorità giudiziaria. La decisione non è discrezionale, ma deve essere basata sulla valutazione della sussistenza dei presupposti di legge e, in particolare, sull’eventuale presenza del fondato sospetto che l’azione giudiziaria sia stata avviata con finalità persecutorie o per impedire l’esercizio delle funzioni parlamentari.
La delibera della Camera è un atto politico-costituzionale e non un giudizio di merito sull’accusa. Le procedure interne delle Camere prevedono che la richiesta sia esaminata da una Giunta per le autorizzazioni a procedere, la quale redige una relazione sottoposta poi al voto dell’Assemblea.
Ruolo della Corte Costituzionale sull’immunità parlamentare
La Corte Costituzionale ha un ruolo centrale nel garantire il corretto bilanciamento tra immunità parlamentare e indipendenza della magistratura, in quanto è competente a giudicare sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, qualora un’autorità giudiziaria ritenga che la Camera abbia indebitamente negato o concesso l’autorizzazione, o qualora una Camera ritenga che un’autorità giudiziaria abbia agito in violazione delle prerogative parlamentari.
Attraverso le sue sentenze, la Corte ha esplicitato i limiti dell’insindacabilità e dell’inviolabilità, chiarendo quando le dichiarazioni di un parlamentare possano considerarsi, come detto, “funzionali” all’esercizio del mandato e quando invece esulino da tale ambito, divenendo suscettibili di giudizio ordinario.
Percezione pubblica dell’immunità parlamentare
Nonostante la sua chiara finalità di tutela istituzionale, l’immunità parlamentare è stata e continua ad essere oggetto di un acceso dibattito pubblico e politico e, talvolta, di una percezione distorta. Spesso viene interpretata come un privilegio che pone i parlamentari al di sopra della legge comune, alimentato da casi in cui l’immunità è stata invocata, o percepita come tale, per sottrarsi a responsabilità penali. Al riguardo, è importate ripetere che l’immunità non conferisce l‘impunità e un parlamentare che commette un reato è, e deve essere, chiamato a risponderne come qualsiasi altro cittadino, una volta cessato il mandato o qualora non siano necessarie le garanzie procedurali previste dall’articolo 68.
Proprio in quest’ottica, la riforma del 1993 ha segnato un passo importante verso una maggiore trasparenza e un riequilibrio del rapporto tra Parlamento e magistratura, cercando di superare le criticità emerse nel passato, pur continuando ad alimentare perplessità soprattutto per quel che concerne la credibilità delle istituzioni, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l’efficienza della giustizia.
In questo contesto, la corretta informazione e la costante vigilanza sul rispetto dei principi costituzionali rappresentano gli elementi centrali per una piena comprensione e accettazione di un istituto che, seppur complesso, è essenziale per la sopravvivenza del sistema democratico.