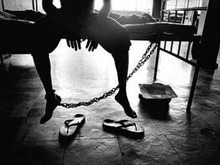La questione della bestemmia, e più in generale della blasfemia, nell’ambito giuridico italiano è un tema che ha subito diverse modifiche nel corso del tempo, riflettendo i mutamenti sociali, culturali e l’evoluzione dei principi costituzionali, in particolare quello della laicità dello Stato e della libertà di pensiero e di espressione.
Da reato penale, la bestemmia è stata depenalizzata, configurandosi oggi come un elemento di illecito amministrativo, che può comportare una pena pecuniaria variabile.
In questo articolo parliamo di:
Contesto storico: dal reato penale a infrazione amministrativa
Per lungo tempo, la bestemmia è stata considerata un reato nel Codice Penale italiano, specificamente all’articolo 724, intitolato “Bestemmia contro le divinità o i simboli o le persone venerati nello Stato”.
La formulazione originale di tale articolo puniva chiunque “pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone divinizzati o venerati secondo le leggi dello Stato“, con una norma, risalente all’epoca fascista (Codice Rocco del 1930), che rifletteva un contesto storico e politico in cui la religione cattolica godeva di uno status privilegiato e la tutela del sentimento religioso era concepita in modo più rigido, con un’enfasi sulla protezione di ciò che era considerato sacro per la maggioranza della popolazione.
L’avvento della Costituzione Repubblicana
Tuttavia, con l’avvento della Costituzione Repubblicana (1948) e l’affermazione dei principi di libertà di pensiero (articolo 21 Cost.) e di uguaglianza di fronte alla legge senza distinzioni di religione (articolo 3 Cost.), nonché della laicità dello Stato, l’articolo 724 del Codice Penale iniziò a contrapporsi a questa disciplina.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con diverse sentenze, ha progressivamente minimizzato l’importanza di questa norma, in particolare con la sentenza n. 440 del 1995, quando la Consulta dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’espressione “o i Simboli o le Persone divinizzati o venerati secondo le leggi dello Stato”, limitando la punibilità della bestemmia unicamente a quella rivolta contro la Divinità. La Corte sottolineò che l’articolo non poteva proteggere indistintamente tutti i culti, ma solo il sentimento religioso in sé, e comunque in modo non discriminatorio, rappresentando il primo passo verso la depenalizzazione totale.
Depenalizzazione e attuale quadro normativo
La svolta definitiva si ebbe con la Legge 24 giugno 1999, n. 205, che introdusse “Disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema sanzionatorio”, abrogando l’articolo 724 del Codice Penale, trasformando la bestemmia da reato penale a illecito amministrativo.
La nuova disposizione, inserita nell’articolo 724 del Codice Penale ma con un testo completamente riscritto prevede che “chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309″.
Cosa rischia chi bestemmia in pubblico?
Ciò ha significato che la presenza di una bestemmia non comporta più conseguenze penali (come la fedina penale macchiata o la detenzione), ma solo una sanzione pecuniaria. La competenza per l’accertamento e l’applicazione della sanzione è passata dagli organi giudiziari a quelli amministrativi, tipicamente le prefetture. La natura pubblicistica dell’illecito richiede che la bestemmia sia pronunciata in luogo pubblico o aperto al pubblico, o comunque in circostanze tali da poter essere percepita da un numero indeterminato di persone. La volontarietà dell’azione, intesa come consapevolezza di proferire parole oltraggiose, è comunque un elemento costitutivo dell’illecito.
Cosa costituisce “bestemmia” oggi
Con la depenalizzazione e le precedenti pronunce della Corte Costituzionale, la definizione di “bestemmia” ai fini sanzionatori si è notevolmente ristretta. Attualmente, l’illecito amministrativo di bestemmia sussiste solo se le espressioni oltraggiose sono rivolte esclusivamente contro la Divinità in sé. Ciò significa che non rientrano più nell’ambito della sanzionabilità amministrativa le invettive o le parole oltraggiose rivolte contro i Santi o la Madonna, le persone o i simboli venerati da una religione (come ad esempio la croce, un’icona sacra, o figure religiose) e la religione in generale o i suoi dogmi.
Ciò significa che insultare i Santi, la Madonna, o simboli religiosi non costituisce più bestemmia ai sensi dell’articolo 724, bensì potrebbe, in determinate circostanze, ricadere sotto altre fattispecie di reato (sebbene meno comuni e più difficili da provare), come il vilipendio della religione dello Stato (Art. 402 c.p.) o il vilipendio di persone o cose (anche) religiose (Art. 403 c.p.), che però richiedono un intento specifico e un contesto ben preciso, e sono anch’essi stati oggetto di depenalizzazioni e modifiche per adeguarli al principio di uguaglianza dei culti e alla libertà di espressione.
Le sanzioni per la bestemmia
Come accennato, la sanzione per la bestemmia è di natura pecuniaria, con un importo che varia da 51 euro a 309 euro. La contestazione dell’illecito può essere elevata dalle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale) che abbiano accertato la violazione. Successivamente, il verbale viene trasmesso alla Prefettura competente per territorio, che procede all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento. L’interessato ha la possibilità di presentare scritti difensivi o chiedere di essere sentito prima che la Prefettura adotti il provvedimento finale. In caso di mancato pagamento, si applicano le procedure di riscossione coattiva previste per gli illeciti amministrativi.
Una applicazione della sanzione molto rara
È importante sottolineare come l’applicazione di questa sanzione sia, nella pratica, relativamente rara. Spesso, le autorità tendono a intervenire in casi di manifesta e reiterata condotta oltraggiosa, o quando la bestemmia assume un carattere di disturbo dell’ordine pubblico o di palese inciviltà, piuttosto che per una singola espressione involontaria. Al riguardo, la discrezionalità nell’applicazione è quindi molto elevata e dipende essenzialmente dal contesto e dalla gravità percepita dell’offesa.