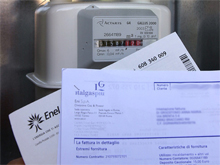La volatilità è un concetto cardine nel mondo dell’economia, specificatamente della finanza, e rappresenta la misura delle fluttuazioni al rialzo o al ribasso dei prezzi di un’attività finanziaria, come un’azione, un’obbligazione o una commodity, in un determinato intervallo di tempo. Tecnicamente, la volatilità è un indicatore statistico che quantifica quanto i rendimenti di un asset si discostano dal loro valore medio. Più grandi e frequenti sono queste variazioni, più un titolo è considerato volatile, e questo ne segnala l’incertezza sul mercato.
È importante sottolineare che la volatilità è una caratteristica inevitabile e intrinseca dei mercati finanziari, specialmente per gli investimenti a lungo termine. I mercati, infatti, tendono a reagire bruscamente e talvolta in modo eccessivo a eventi economici, politici, geopolitici e aziendali che generano incertezza, precludendo le prospettive a breve termine.
In questo articolo parliamo di:
Come misurare la volatilità
La misurazione più comune della volatilità storica è la deviazione standard, un indice statistico che indica quanto i prezzi oscillano intorno alla media. Oltre alla volatilità storica, calcolata sulla serie passata dei rendimenti, esiste la volatilità attesa (o implicita), che stima quanto un titolo potrà essere volatile in futuro, sebbene, trattandosi di una stima, contenga per definizione un margine di errore.
Un altro strumento ampiamente utilizzato è l’indice VIX (Volatilità Index), spesso soprannominato “l’indice della paura“, che monitora l’andamento delle previsioni di volatilità implicita nel mercato azionario di Wall Street e tende a salire notevolmente quando l’incertezza aumenta.
La volatilità aiuta gli investitori a comprendere il livello di rischio associato a un determinato asset o mercato e a confrontare diverse opportunità di investimento: a una maggiore volatilità, infatti, corrispondono in genere maggiori opportunità di guadagno, ma anche un rischio più elevato di perdite.
I rischi associati all’elevata volatilità
L’alta volatilità è spesso correlata a un elevato rischio di mercato, poiché comporta la possibilità di subire notevoli variazioni negative del valore dell’investimento. Sebbene la volatilità non sia intrinsecamente negativa, la sua rapida e ampia manifestazione solleva diversi rischi che l’investitore deve considerare.
Il rischio più immediato è quello di perdita di capitale, specialmente se l’investitore è costretto a vendere le proprie attività in un momento di ribasso, consolidando di fatto una perdita che, se si fosse atteso il recupero, avrebbe potuto essere solo temporanea. La volatilità acuisce anche l’effetto dei bias comportamentali o rischi psicologici. Nelle fasi di incertezza, la componente emotiva, come l’ansia o la paura, può prevalere sulla razionalità. Questo porta i risparmiatori, anche ben informati, a prendere decisioni impulsive, come disinvestire in momenti di panico, un fenomeno che si scontra con il principio fondamentale dell’investimento a lungo termine.
Inoltre, strumenti finanziari complessi, come quelli che utilizzano la leva finanziaria o i derivati come le opzioni, amplificano in modo significativo gli effetti della volatilità. L’uso di una leva finanziaria elevata può provocare, in caso di esiti negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio iniziale conferito, creando una situazione di debito verso l’intermediario.
Anche il rischio di cambio (per gli investimenti internazionali) è strettamente legato alla volatilità, poiché le fluttuazioni valutarie possono condizionare pesantemente il risultato complessivo dell’investimento, dato che i rapporti di cambio, soprattutto in alcuni mercati, possono essere estremamente instabili.
Per tutti questi motivi, la CONSOB, l’autorità italiana per la vigilanza sui mercati finanziari, enfatizza la necessità per l’investitore di comprendere a fondo questi meccanismi e i relativi rischi prima di intraprendere qualsiasi operazione.
I fattori scatenanti, volatilità e rischio sistematico
La volatilità è spesso innescata da una combinazione di fattori macroeconomici, politici e persino emotivi. Le turbolenze politiche o geopolitiche, i cambiamenti inattesi nelle politiche monetarie delle banche centrali, i dati economici al di sotto delle aspettative (come i rapporti sull’occupazione o l’inflazione), e gli shock globali (come pandemie o crisi energetiche) sono tutti fattori noti per alimentare una fase di elevata volatilità e i mercati finanziari, non amando l’incertezza, reagiscono con nervosismo a questi eventi.
Nel risk management, è fondamentale distinguere tra la volatilità del singolo asset e il rischio sistematico del mercato nel suo complesso. Il rischio sistematico, non diversificabile, è misurato attraverso il coefficiente Beta, che misura la correlazione tra la variazione del rendimento di un titolo specifico rispetto al mercato di riferimento.
Un titolo con Beta superiore a 1 indica che è più volatile del mercato e, di conseguenza, più rischioso (e potenzialmente più redditizio), mentre un Beta inferiore a 1 indica un rischio inferiore alla media del mercato. La distinzione è fondamentale per gli investitori che mirano a comprendere se la rischiosità del loro portafoglio derivi da fattori specifici dell’azienda o da tendenze più ampie del mercato.
Strategie efficaci per la gestione della volatilità
Una gestione professionale e razionale della volatilità può trasformarla da minaccia in opportunità, specialmente per chi mantiene un orizzonte temporale di investimento di lungo termine. Gli esperti di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria concordano su alcune strategie chiave.
La diversificazione è la prima linea di difesa. Essa implica la ripartizione degli investimenti su diverse classi di asset (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, immobiliare, liquidità) e mercati, in modo che l’andamento negativo di una componente possa essere bilanciato dall’andamento positivo di un’altra. In questo modo, il rischio specifico dei singoli asset viene ridotto.
Il Piano di Accumulo Capitale (PAC) è una strategia che sfrutta la volatilità a favore dell’investitore. Mediante versamenti periodici e costanti, l’investitore acquista quote a prezzi diversi, compresi quelli più bassi durante le fasi di ribasso, beneficiando del cosiddetto cost averaging. che aiuta anche a superare la tentazione di reagire emotivamente alle fluttuazioni di breve termine.
L’importanza del ribilanciamento
Infine, il ribilanciamento periodico del portafoglio è essenziale. I mercati in forte crescita o contrazione alterano la composizione originaria del portafoglio, esponendolo a un rischio non voluto. Ribilanciare significa riportare le percentuali di investimento alle quote iniziali desiderate, vendendo asset che hanno sovraperformato e acquistando quelli che hanno sottoperformato, spesso approfittando proprio dei momenti di alta volatilità per riallineare il rischio al profilo dell’investitore.
L’approccio di lungo termine e una preparazione iniziale agli inevitabili episodi di volatilità sono essenziali per non farsi sorprendere e per reagire in modo razionale.